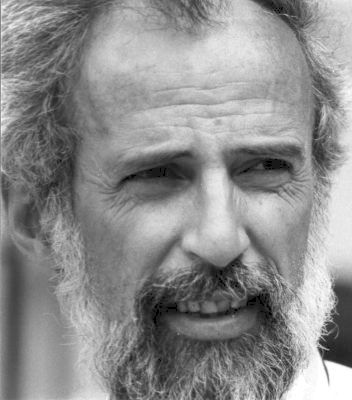
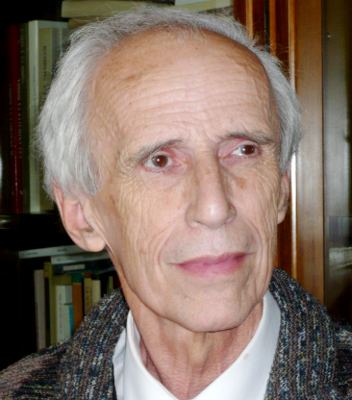
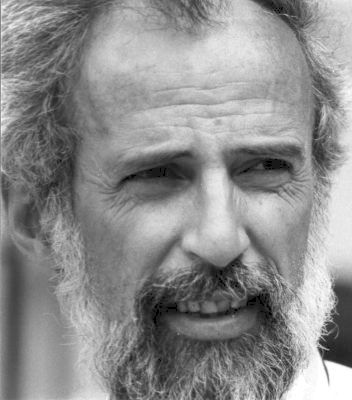
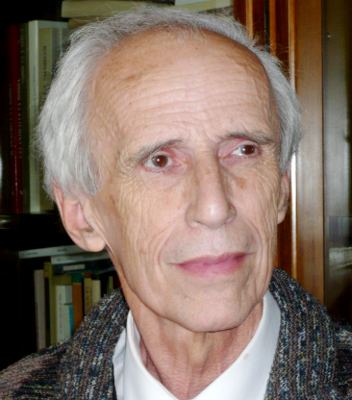
La celebre partita a scacchi del cavaliere con la morte ne Il settimo sigillo
è un tema classico, approdato alla cinematografia dopo lunga navigazione nei mari della letteratura e della pittura. È un'immagine bella e significativa, ma non cessa di essere altro che una surreale metafora. «Mai – insegna Epicuro – possiamo incontrare la nostra morte. Fino a che siamo, essa manca; quando lei si presenta, noi già ce ne siamo andati». La morte è un'assenza, l'assenza definitiva che, col suo potere nullificante, invade la vita nostra e altrui e, come conscia o inconscia attesa, nel male e nel bene, la permea e la alimenta.
Se è vero che: «Principio di morte è il nascimento» e che: «Autentica esistenza è quella vissuta per la morte», è vero perché la vita, nei suoi risvolti culturali e spirituali piú nobili e piú ignobili, è debitrice verso la morte. Chi non sa che tra le prime testimonianze della civilizzazione stanno le tracce dei rituali funerari paleolitici, spesso non esenti da, altrettanto rituali, sacrifici umani? Chi ignora che la storia ben conosce il tragico risvolto della paura della morte combattuta con gli strumenti classici della sua esorcizzazione: la ricerca di capri espiatori e l'autopunizione? Chi può negare che attribuire al diavolo l'origine del peccato e della morte comporti una sorta di demonizzazione della vita? Chi non ha presente che la poesia e tutte le altre arti, per tacere delle religioni e della medicina, pongono tra le proprie cause finali l'umano bisogno di fronteggiare, elaborare e superare il lutto? Chi non ha sperimentato che le radici delle passioni traggono vigore dalla polarità amore-morte
? Chi può trascurare il fatto che diritto, economia e ogni altra forma di organizzazione sociale tentano di regolare i rapporti tra vivi, occupandosi anche di quelli coi morti?
La morte dunque aggredisce la vita e, aggredendola per nullificarla, oltre a sfigurarla e abbrutirla, la stimola a rigenerarsi a livelli sempre piú alti. Per questo la sapienza ricorda all'uomo che se la coscienza della morte può tradursi nell'esaltazione dell'istinto alla violenza, essa può diventare altresí per lui la riscoperta e la valorizzazione del suo vero onore
. È tale coscienza infatti, unita agli stimoli fisici ed emotivi, che internamente lo animano, a generare in lui il tentativo di dare senso al dispiegarsi della propria finitudine.
Gli dei sono gli immortali
; gli uomini sono i mortali
; ma solo ai mortali è dato crescere verso la trascendenza. L'immortale, che vuole rendere onore al suo stato di trascendente, non può accontentarsi di stare gelosamente fisso in esso, pena il rischio della propria satanizzazione. Deve quadagnarselo, facendo propria la finitudine usque ad mortem nel rischioso orizzonte della compiuta fedeltà dell'Uno ai molti.
Per mortali e immortali il cammino è lo stesso. È il cammino, senza reti di sicurezza, sul filo di un'esistenza teso tra un inizio e una fine di cui non si possono verificare consistenza e solidità. Un filo che attraversa un intrico di fili, dove un'indefinita molteplicità di acrobati si incontra e si scontra, si spintona e si sorregge in equilibrio piú o meno precario, piú o meno felice.
Ecco perché ogni umana parola sulla morte, che esprima accettazione o rifiuto del suo potere distruttivo, che si soffermi su quanto la precede e la segue, che si riferisca al proprio e altrui non essere piú
o essere altrimenti
, si articola sempre come narrazione di eventi che aprono a dimensioni inoggettivabili della realtà ed evocano la tipica simbologia del surreale.
È cosí che, nel bianco e nero dell'acquaforte düreriana, la pellicola di Bergman riattualizza, sullo sfondo di un emblematico medioevo, temi apocalittici e apocalittiche rivelazioni sul trapasso. Ed è cosí che, con le molto piú prosaiche e colorate immagini analogiche de Le invasioni barbariche
, ci troviamo immersi nella corrosiva tragi-commedia dell'ultimo miglio ospedaliero di un post-moderno Terminale
. Due film imparagonabili, separati da cinquant'anni di storia che, con linguaggio, sensibilità, riferimenti culturali alternativi, prospettano le potenzialità orrifiche e salvifiche custodite dall'esperienza dell'umana mortalità, orientandosi infine, con diversa leggerezza, verso la valorizzazione di queste ultime.
Si muove in tale orizzonte l'avventura del cavaliere che gioca con la morte per dilazionarne la vittoria, in attesa di trovare uno scopo al proprio esistere, e che, in ultimo, dopo avere attraversato un mondo dominato dal terrore distruttivo della peste, si lascia vincere per sottrarle dalle mani la semplice famiglia di un saltimbanco visionario. Sarà quest'ultimo a descrivere la fine dell'avventura come il passo di danza con cui il cavaliere e gli inseparabili compagni, guidati dall'ombra della grande falce, vanno verso un mondo ignoto di pace oltre le colline e le nuvole, nella luce dolcissima dell'alba.
Nè indirizza altrove la narrazione del percorso alla morte dell'anziano professore, amante delle donne e della tavola. Percorso che, traformando il dramma in commedia, offre lo spunto per un'imprevedibile e forse non del tutto improbabile valorizzazione del potere umanizzante di quanto vi è di piú disumanizzante: la seduzione corruttrice del denaro, la violenza distruttiva del dolore, della droga, dell'indifferenza, della morte.
Se cosí possiamo leggerli, questi due film, per vie diverse, suggeriscono che forse, l'incontro col male non solo in male si perpetua, ma anche cova embrioni di bene. Diciamo forse, perché il forse è la sola espressione del quotidiano parlare che può laicamente custodire la dimensione umana della speranza in una cultura totalmente secolarizzata, in un linguaggio fedele alla terra e alla finitudine degli esseri. Diciamo forse
, perché l'esito riconciliante con la vita, che l'esperienza di corale sostegno al morire del protagonista de Le invasioni barbariche
sembra avere prodotto nella maggior parte dei co-agonisti, può dirsi acquisito al momento in cui la compagnia si scioglie e la messa in scena termina. Ma nessuna voce fuori campo garantisce che tutti per sempre vivranno «felici e contenti».
La presenza attiva di un Deus ex machina al morire non serve, a meno che non sia, come per Bergman, quella della morte stessa, rivelata, non da un vate o da un profeta, ma da un buffone innamorato e volentieri deriso.
Aldo Bodrato, aprile 2011
(Questo testo, è stato pubblicato sul sito web del mensile Esodo)
Per commenti o segnalazioni, potete scrivere all'autore: <>.