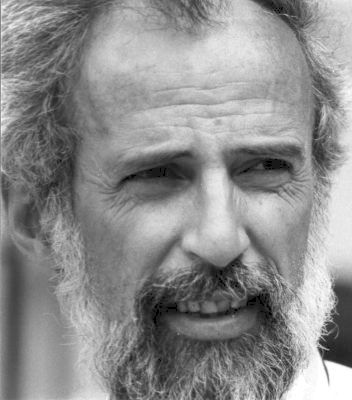
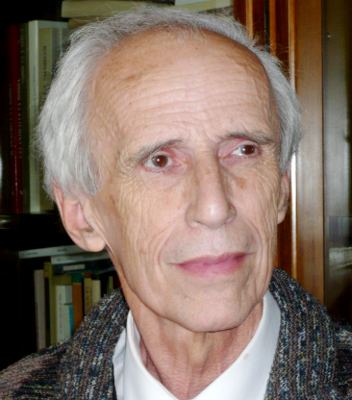
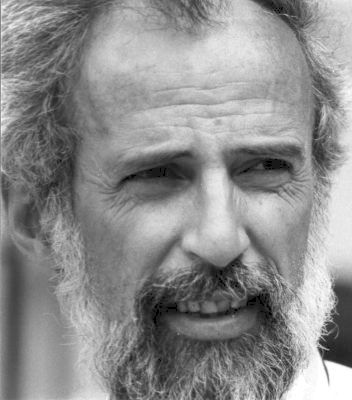
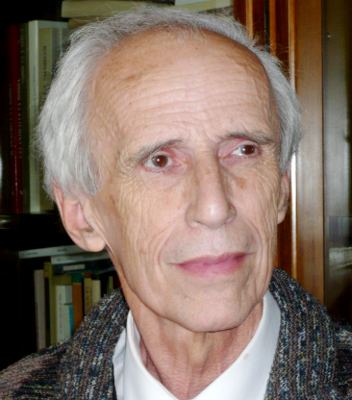
qui-dopodell'immortalità
Il buio, prima di essere assoluto, è ombra in cui sbiadiscono vaganti chiarori e, anche dopo, se come buio persiste, è sempre visione. L'assenza genera un vuoto e il vuoto invoca il segno di una lontananza, proprio come il silenzio rimanda al ricordo e all'attesa di un suono, il muto trabocca di parole non dette e il sordo di non udite. Cosí è del Hereafeter
di Clint Eastwood: un aldilà che solo può darsi in un qui-e-ora proiettato, non tanto in un insondabile oltre, quanto in un raggiungibile altrove.
Il grande regista affronta infatti il tema del prima e dopo morte sulla base di una sceneggiatura che lo vive e lo pensa nell'orizzonte unitario e pacificante dell'immortalità e non nella prospettiva traumatica del confronto tra il dramma storico della definitività della morte e l'inaudito annuncio di grazia della resurrezione.
Il che non toglie valore alla difficile ricerca del film di dare voce e volto credibili a un tema per lo piú trattato con risibile superficialità, ma al tempo stesso può aiutarci a capire perché esso non tocchi quei vertici di verità esistenziale, raggiunti da Eastwood in altre pellicole, come Gran Torino
e Million Dollar Baby
.
Nella sua acuta analisi di questo lavoro, Gabriele Barrera qualifica le tre esperienze umane, che col loro dipanarsi e sovrapporsi danno anima e vita al film, con tre logoi.
«Cosa significa essere prossimi alla morte? … Ce n'est qu'un moment (non è che un momento)». Il primo logo caratterizza cosí la vicenda della giornalista francese travolta dallo tsunami e portata alle soglie della morte, percepita come un fluttuare tra ombra e luce verso una meta imprecisata, ma definitiva, di pace.
«Cos'è la morte? … Ce n'est qu'une absence»: recita il secondo. Non è che un'assenza traumatica la morte del gemello per l'adolescente che sopravvive. Un'assenza traumatica che ne blocca lo sviluppo emotivo e relazionale in una situazione familiare già fortemente intaccata dalla fragilità della madre drogata e dalla completa latitanza di un padre, neppure nominato. Un'assenza che fa della solitudine un'isola da cui solo un traghettatore di anime può aiutare a fuggire.
«Cos'è la fine? … Ce n'est qu'une douleur»: conclude il terzo logo a riassumere la vicenda dell'operaio quarantenne che, a seguito di una malattia infantile, si trova a possedere il dono-maledizione
di poter tradurre in visione le tracce sanguinanti di un lutto, mai consolato, e di riallacciare per un attimo il contatto emotivo tra la vittima dell'assenza e l'assente.
Il resto della storia è la messa in opera di quanto può provocare l'incontro tra queste tre esperienze umane, vissute da ciascuno dei protagonisti come una ferita da risanare, che si risana davvero solo quando poco piú che il caso li mette uno sulle tracce dell'altro e la necessità, in un misto di sofferenza e di speranza, con passione, internamente li spinge uno nelle braccia dell'altro.
Il che spiega l'happy end conclusivo, che ha lasciato scettico piú di uno spettatore e di un critico per la sua apparente facilità, e che invece risulta essenziale allo sviluppo della tematica del film.
Come osserva ancora Gabriele Barrera, solo con questo esito la vicenda poteva rendere plausibile la pur fragile apertura ad una riflessione, non piú che possibile, sull'aldilà. Apertura che dà luogo ad un quarto logo: «Cos'è, infine, l'aldilà? … Ce n'est qu'un espoir»: una speranza che ha potere esistenzialmente risanatore e su questo potere, totalmente terreno, fonda la propria credibilità
. Non fonda la propria verità
; visto che nessun passaggio del film dal quotidiano al metafisico consente di afferrarne una.
Barrera nota che l'istantanea visione
di un bacio, nato dall'occasionale sfiorarsi delle mani della giornalista e del veggente
, è la chiave simbolica, il dettaglio esclamativo
, che aiuta a qualificare la loro esperienza di traghettatori delle anime oltre la barriera della morte come capacità di dare voce e volto al fondamentale desiderio umano di continuità e comunione. E a ragione conclude: «il soprannaturale resta per sempre escluso dall'orizzonte cinematografico dell'hereafter eastwoodiano» (Clint Eastwood e la dolorante proiezione dell'aldilà, laicità
1, III, 2011, p. 9).
Concordo con lui, sull'analisi e sul giudizio del significato culturale e poetico del film. Solo mi permetto di osservare che dal punto di vista filosofico-teologico nulla di veramente soprannaturale potrebbe mai venirci incontro nell'orizzonte culturale in cui il film pone il tema dell'aldilà. Questo, neppure se Eastwood facesse proprie, nelle sue specifiche implicazioni metafisiche, la dottrina platonica dell'immortalità, a suo tempo elevata a dogma dal cristianesimo tradizionale.
La metafisica tratta, infatti, l'essere dell'anima, prima e dopo la morte, come un dato di assoluta e certa continuità naturale e abbandona la sola e provvisoria unità materiale del corpo al potere disgregatore della morte. Col che sterilizza ogni possibile lettura traumatica e drammatica del morire, ponendosi in perfetta e voluta contraddizione, sia coi dati dell'umana esperienza, sia con la narrazione evangelica della morte di Gesú il Cristo, sia, ancora, con la conseguente inconcepibilità dell'annuncio di resurrezione.
L'intrinseca contradditorietà del paradosso: Il Crocefisso è risorto
non genera solo la figura retorica di un ossimoro, fonte di infinite creazioni d'arte e di pensiero, ma con tutte le sue implicazioni tragiche e comiche, con la sua accettazione della piena e ineludibile definitività della morte e dell' imprevedibilità della vita, apre all'umana fragilità orizzonti che vanno oltre ogni ragionevole speranza di eternità
.
Ma questo è tema che dovrà essere affrontato in altra occasione. Qui è importante segnalarlo per aiutare a interrogarsi sul, non risolto e probabilmente irresolvibile, rapporto dell'uomo con la morte che questo film evidenzia, in modo piú problematico e, direi, meno efficace, di altre opere dello stesso autore.
Aldo Bodrato, aprile 2011
(Questo testo, verrà pubblicato sul sito web del mensile Esodo)
Per commenti o segnalazioni, potete scrivere all'autore: <>.