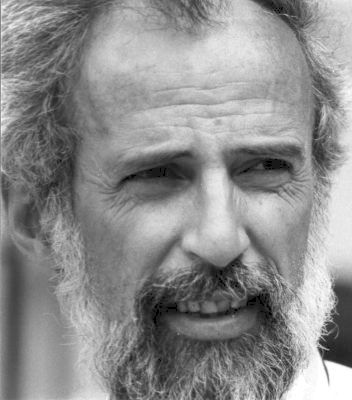
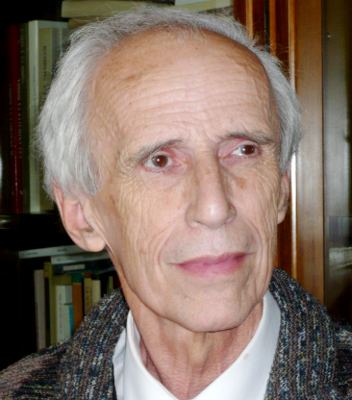
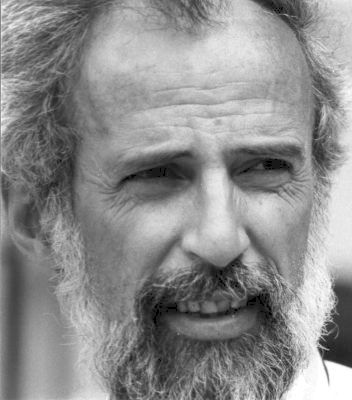
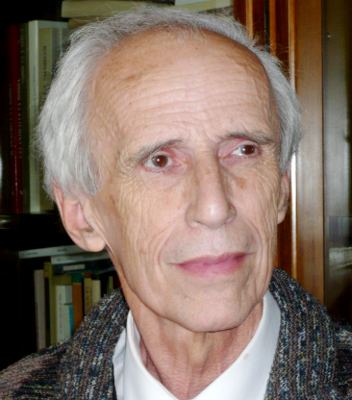
Fin dalla prima metà del '300 Guglielmo d'Ockham - da buon francescano che ha sempre nell'animo il mistero dell'incarnazione e ricorda commosso le umiliazioni e le privazioni che essa comportò: misera nascita, fuga in terra straniera, lavoro manuale a Nazaret, stenti e disagi della predicazione, morte da schiavo in croce – rifiuta l'identificazione papale (Giovanni XXII) della regalità davidico-universal-escatologica del Cristo
con una qualsivoglia forma di regalità storica, capace, diremmo noi oggi, di fondare una storica Dottrina sociale cristiana
. Scrive, infatti nell'Opus nonaginta dierum del 1324 (674-681): «In quanto uomo mortale non era re a regendo temporaliter... Non aveva regno tale, quale est regnum mundanum et humanum... Mai rivendicò per sé il supremo potere temporale, in quanto non convocava parlamenti e curie, non si faceva giudice di questioni civili o penali, non combatteva nemici, né teneva eserciti al soldo, né esercitava altre funzioni tipiche dei regimi-terreni». (Marino Damiata, Guglielmo d'Ockham, povertà e potere, vol I, Studi Francescani
, 1978, n. 1-4, p. 452).
batte moneta
Ciò che colpisce nei testi, dedicati da Santa Romana Chiesa ai temi della cosiddetta dottrina sociale cristiana
, è l'assenza di qualsiasi tensione escatologica. Assenza che obbliga ogni discorso cristiano sulla realtà e sulla prassi etica del credente ad appiattirsi a livello di pura e corretta gestione e conservazione del presente storico, quasi esso, con le sue prassi economiche e sociali, fosse l'unico possibile. Ecco perché, invece di affrontare il controverso problema del rapporto del cristiano col denaro a partire dall'ultima enciclica (Caritas in veritate, primavera 2009), ci poniamo in un'ottica tutta diversa. Non interroghiamo il magistero e la tradizione e neppure la teologia, ma, proprio come i Poverelli di Francesco
al tempo dell'Esilio avignonese
, ricorriamo direttamente al testo evangelico e ci chiediamo: «Cosa possiamo ricavare dalla narrazione originaria della predicazione e dell'azione di Gesú a proposito del denaro e del suo uso? Quale modello di azione socio-economica consegue alla proposta di convertirsi al Regno che egli inaugura?».
Partiamo da un passo noto, che non esige premesse o sintesi narrative. A Gesú è domandato se è lecito
ad un ebreo, che riconosce Dio come solo Signore, dare il tributo a Cesare
. Gesú si fa porgere il soldo del tributo; è denaro che porta l'immagine di Cesare; quindi conclude: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mc 12, 13-17).
In genere si riflette a questo proposito sulle pratiche relative al dovere sociale ed etico di ogni cittadino di pagare le tasse allo stato di cui usa la moneta. Questa, però, non è l'unica questione che il passo ci pone. Dietro ad essa ne sta nascosta un'altra di tipo squisitamente teologico.
La cogliamo subito se ci chiediamo che tipo di potere sia quello di Dio, visto che a Lui si deve la restituzione di quello che ha dato e che quanto ha dato non ha nulla a che fare col denaro coniato dai regni di questo mondo, ma è di tutt'altro ordine e valore. È doveroso domandarselo per un credente, visto che la rivendicazione di questo potere gli viene presentata dai vangeli stessi come presenza di un regno a cui bisogna convertirsi
, un regno che, a quanto pare, non può neppure porsi il problema di battere moneta
. Il suo Signore, infatti, non essendo un idolo, ma un Dio indicibile e non figurabile, neppure può simbolicamente prendere forma in un oggetto che lo renda operativamente presente, come una moneta, coniata per evocare la ricchezza e il potere di colui che ne garantisce liceità d'uso e valore di scambio. Dunque: di che regno parla mai Gesú se in esso la Signoria
non ha corso come denaro, vale a dire come valore monetizzabile e quantificabile nella forma oggettiva di una qualsivoglia potenza o ricchezza materiale?
La questione non è peregrina, se teniamo presente quanto Marco mette in bocca a Gesú in risposta alla ricerca di ruoli di prestigio nel regno da parte dei figli di Zebedeo: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi della nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse potere. Fra voi però non è cosí; ma chi vuol essere grande tra voi si farà servitore ... Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto di molti» (10, 42-45).
Nec nubent nec nubentur
Ma questo è solo uno dei versanti che segnano la radicale alterità del regno di Dio rispetto ai regni degli uomini. Nello stesso capitolo 12 di Marco, a continuazione della questione del tributo, è posta la questione della resurrezione dei morti con l'esempio della sposa dei sette fratelli (12, 18-26). Solo in parte la questione riguarda un tema diverso, quello dello stato escatologico dei risorti. In realtà anche questo problema ha a che fare con la diversità tra il regno di Dio, cui i risorti apparterranno e che Gesú è venuto a inaugurare, e la società terrena con le sue regole e le sue leggi matrimoniali.
Non solo Gesú ci dice che nel suo regno il valore del denaro e il potere della ricchezza e della potenza mondana non hanno corso, ma che neppure hanno corso le leggi che regolano la vita familiare. Nel regno di Dio, infatti, né ci si sposa, né si viene sposati
. Si è come angeli
. Immagine in nessun modo oggettivabile come castità o verginità fisica, ma simbolicamente raffigurabile come nuova entità spirituale in cui l'amore e la relazione interumana, compresa quella uomo-donna, hanno una dimensione totalmente nuova e libera di espressione.
Anche questo passo va tenuto presente insieme a molti altri per capire la dimensione teologica del regno di cui parla Gesú e per cogliere l'originalità di ciò che egli vuole proporre, come originalità di stile di vita, orientata non al possesso, ma al dono.
Che la strada qui imboccata per far luce sulla questione del rapporto tra regno o sequela di Gesú e denaro non sia gratuita ce lo fa capire Marco stesso che cosí continua il suo capitolo: «Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva loro ben risposto (in tutti e due i casi, s'intende), gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti?» (12, 28 e ss).
Sappiamo come prosegue il testo e come Gesú ponga in stretta relazione tra loro: l'unicità di Dio, l'amore a Lui e l'amore al prossimo, facendone i due comandamenti piú importanti, se non unici. E sappiamo pure che le sue parole trovano eco piena nella conferma dello scriba, che, proprio per aver riconosciuto questo primato dell'amore, viene dichiarato: Non lontano dal regno di Dio
.
A quanto pare, infatti, la questione del rapporto tra Gesú e il denaro va posta in quest'ottica di primato dell'amore su ogni altro valore. Ottica che ci fa davvero capire perché, chi serve Dio, che è amore, non può servire mammona
, cioè il denaro come potere, come valore supremo e idolo sociale (Mt 6, 34); ci fa capire perché è tanto difficile per i ricchi entrare nel regno (Mc 10, 23; Lc 18, 24). Il vero ostacolo non è il denaro, ma la mancanza d'amore, che si manifesta nel momento in cui il denaro riesce a prendere il sopravvento, trasformando l'amore, da apertura all'altro, ad attaccamento a ciò che si possiede e ci possiede.
È ancora Marco a darci la prova che non sbagliamo direzione se, invece di demonizzare il denaro, demonizziamo la forza di controllo economico-sociale, unita alla sete del potere in sé. L'intero capitolo in questione si chiude infatti con l'esempio di due atteggiamenti contrapposti. Da una parte abbiamo gli scribi, che amano le lunghe vesti, i primi seggi nelle sinagoghe e nei banchetti, s'appropriano dei beni dei poveri e ostentano religiosa pietà (12, 38-40). Dall'altra la povera vedova, che ha due spiccioli
e li offre, senza esitazione, al tesoro del Tempio. Non è per l'offerta al Tempio che la vedova è lodata, ma per il dono del denaro non in quanto denaro, ma come tutto ciò che aveva per vivere
. È lodata per aver dato la sua vita (12,-44), come il Figlio dell'Uomo
(10, 45).
Gesú e i suoi non facevano uso di monete? Non avevano neanche un borsellino, come pensavano i seguaci del Poverello d'Assisi? Verrebbe da pensarlo, tenendo presenti le raccomandazioni di estrema sobrietà rivolte ai discepoli inviati in missione (Mt 10, 9-10). Ma non è necessario darlo per certo. Ci basta questo singolare modo simbolico di rapportarsi al denaro e al suo uso, in relazione ai regni terreni di Cesare e del Tempio, per capire che, quando Gesú parla di regno di Dio, non ne parla come di un regno fondato sul denaro e sul suo potere, ma del tutto libero da esso e dai suoi inevitabili condizionamenti.
Qui potremmo fermarci. C'è però ancora un passo del capitolo 12 di Marco, che merita particolare attenzione e ci sono poi altri passi da fare nella comprensione del rapporto tra regno
, come comunità dei figli di Dio
e realtà storico sociale delle comunità terrene, compreso un cenno almeno al significato da attribuirsi al termine escatologico
riferito al valore del messaggio e dell'esperienza evangelica (Escatologia ed economia 2, Dare frutti fuori stagione).
Torniamo dunque al capitolo 12 di Marco e alla pericope che abbiamo tralasciato. Si tratta dei versetti in cui Gesú discute la discendenza davidica del messia. Versetti fondamentali per la comprensione del valore che questo vangelo dà alla regalità di Gesú.
E' nota l'importanza attribuita da quasi tutti i gli scritti del Nuovo Testamento alle radici davidiche della messianicità di Gesú. Le ricorda l'Apocalisse (5, 59). Le ricorda Paolo di sfuggita (Rm 1,3). Ci insistono gli Atti per bocca di Pietro (10, 34-43). Rivendica la nascita betlemmita di Gesú il vangelo dell'infanzia di Luca (2, 3-7); ma è Matteo che fa della discendenza davidica di Gesú, attraverso Giuseppe e della visita dei magi a Gerusalemme e a Betlemme, un punto di forza della sua teologia sulla messianicità regale di Gesú (Mt 2), senza mai chiamarlo re dei Giudei
.
Ora questo preciso passo di Marco sembra suonare in netta controtendenza con tutto ciò nel momento in cui mette in bocca a Gesú questo interrogativo: «Come mai gli scribi dicono che il messia è figlio di Davide ... mentre Davide stesso lo chiama mio Signore?» (12, 35-37).
Senza aprire una specifica parentesi sulla cristologia di Marco, ci basti segnalare, che mai i vangeli proclamano la regalità di Gesú, rivendicando il suo diritto al trono di Davide. Accennano al piú ad una regalità messianica, connessa ad una società a venire, presente come fine promesso
, non come stato di fatto acquisibile una volta per tutte. Esaltano una regalità escatologica, che sta in alternativa esistenziale, non in contiguità storico-conflittuale con quella dei vari potentati terreni. In Giovanni Gesú fugge le folle quando teme lo vogliano fare re
(6, 15) e rifiuta l'accusa dei capi Giudei, rinnovatagli da Pilato, di volersi fare re terreno (18, 36); la sua è una regalità legata alla verità
(19, 37).
Del resto anche in Matteo la davidicità di Gesú si riferisce a Betlemme, luogo dell'unzione profetica di Davide ancora bambino, non a Gerusalemme, capitale ed emblema del regno davidico. Ciò rende chiaro che mai la regalità-messianica di Gesú ha qualcosa a che fare coi regni di questo mondo, compresi Giuda ed Israele, e quindi col loro uso di coniare denari e imporre tributi.
La cosa è tanto piú notevole nel momento in cui si confronti quanto sappiamo di Gesú con quanto la storia ci documenta dei movimenti politico-religiosi ebraici, che subito dopo di lui tentano di rinnovare la libera signoria di Gerusalemme. Nel 66, cacciati i Romani, i nuovi capi della città subito battono monete con la scritta: Siclo di Israele
, Gerusalemme Santa
. Proprio come nel 70 Simon Bar Kosebah conia pezzi d'argento intestati a Simone principe di Israele
.
Nulla di simile è, neppure lontanamente, ipotizzabile rispetto alla tipologia regale attribuita dai vangeli al regno proclamato da Gesú. Eppure Gesú muore in croce come un ribelle politico con la scritta, che indica le ragioni della sua condanna in questi termini: Re dei Giudei
(15, 26).
Il regno di Gesú è un regno senza moneta e addirittura senza leggi che regolano i matrimoni e altre essenziali istituzioni sociali. Ma Gesú muore per la falsa accusa di volersi fare re, sul modello degli altri re della storia, proprio come per paura che potesse nascere un re rivale tra i bimbi di Betlemme Erode fa, secondo il midrash teologico di Matteo, compiere l'orrenda strage.
Anche la sola ipotesi che possa esistere un regno che non batte moneta e fonda le relazioni umane sull'amore e sulla reciprocità del servizio, piú che sui vincoli istituzionali, è motivo di violenta preoccupazione per i regni storici dei Cesari e degli Erodi. Anche solo dare a Dio quello che è di Dio
, amarlo sopra ogni cosa e amare il prossimo come se stesso
, vivere una vita in cui il denaro non sta al centro come valore supremo e supremo indice di benessere e di umana pienezza, diventa storicamente rivoluzionario, diventa motivo di terrore per i poteri di questo mondo e li spinge alla repressione piú feroce. Il che non è l'ultimo indice della novità e della forza del messaggio cristiano sull'uso del denaro e sull'uso di ogni forma di potere, compreso quello della legge.
Aldo Bodrato, giugno 2011
(Questo testo, verrà pubblicato sul sito web del mensile Esodo)
Per commenti o segnalazioni, potete scrivere all'autore: <>.