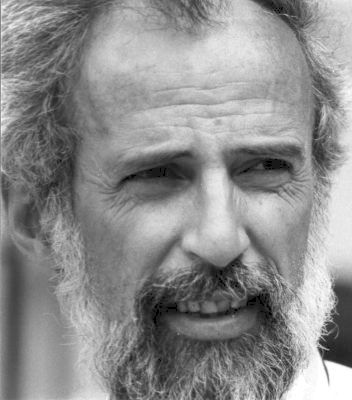
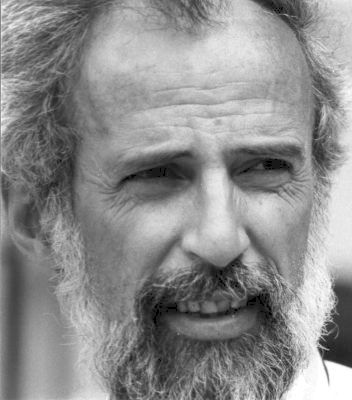
Donde la vita e donde la morte? Nasciamo, non sempre desiderati, dall'incontro tra esseri umani per lo piú consenzienti, e, poiché siamo nati, dobbiamo anche morire, nel caso migliore per consunzione delle energie fisiche vitali a nostra disposizione. Questo lo sappiamo tutti. Quello che non sappiamo è perché nasciamo e che senso abbia il fatto che si nasca per morire. Qualcuno può dire che porsi queste domande è patologico. Appunto: la vita umana, con la sua coscienza e il suo bisogno di senso è una patologia, una gioia, ma anche una sofferenza; perché tanto il gioire quanto il soffrire, ci dicono i filosofi da sempre, sono un patire piú che un agire. Rifugiarsi nella "atarassia", l'indifferenza a-apatica, per tentare di vivere e morire come se non si vivesse e non si morisse, come se non si esistesse, è impossibile persino per Dio, che solo una pessima teologia ha potuto definire "impassibile", non bisognoso, incapace, di gioire e di soffrire.
«Meglio sarebbe non essere nati»: dicono a volte i saggi d'Oriente e d'Occidente, laici e religiosi. Meglio, forse. Ma intanto nati si è e qualcosa bisogna pur farsene, qualche senso a tutto ciò bisogna pur darlo. Impegnarsi a forza, con tutte le energie del proprio essere, come predicano certe correnti filosofiche occidentali e orientali, ad accettare passivamente quanto ci accade è piú impegnativo e penoso che darsi alla dissipazione piú demenziale. Il che è altra cosa dalla mite sottomissione alla quotidianità, tipica dei semplici, dei pazienti, dei puri di cuore, degli assetati di giustizia e di pace. Costoro non negano la vita, ne la esaltano oltre misura, ma se ne fanno carico. Non fingono di non esserci, ma alla vita e alla morte fanno fronte, come sanno, solo cercando di dare ad esse un senso, all'una come all'altra: il senso della loro umile accettazione di qualcosa che a loro sfugge, ma affidano ad Altri, mossi da una qualche fede. Se Dio c'è, stanno nelle sue mani: Se non c'è, vivono e muoiono nell'orizzonte pacificante di tale loro fiducia e questa è la loro ricompensa. Ma guai se il dubbio li assale o il male si fa persistente e intollerabile. Allora l'angoscia e la protesta di Giobbe è il loro destino, raramente con finale riscatto.
La vita e la morte, infatti, sono strettamente legate. Non sono l'opposto logico l'una dell'altra. Nel ciclo naturale ed evolutivo degli esseri non senzienti sono reciprocamente essenziali e senza l'una l'altra non si dà. Diventano l'opposto, entrano in tensione insanabile quanto all'esserci si aggiunge il sentire e ancor piú il crescere e maturarsi della coscienza, la capacità del soffrire e del gioire, del progettare e del pensare. L'esserci in forma di viventi, resi per questo responsabili di se stessi.
È questa la patologia cui accennavamo ed è una patologia, frutto intelligente o casuale dell'evoluzione, contro cui c'è ben poco da fare, se non prendersela in carico come destino. Sta qui oggi il problema della della nascita e della morte. Non si tratta di decidere se ci sono o non ci sono, se possiamo o non possiamo evitarle, ma come dobbiamo affrontarle, dando in questo modo un senso all'una e all'altra. Dare senso alla nascita, come e ovvio e al suo dipanarsi in vita, ma dare senso anche alla morte e al processo del morire che ad essa ci porta. La morte è la fine della vita, ma il morire è ancora un atto di vita. L'ultimo in nostro possesso. Anche ieri lo era, ma molto meno. Oggi lo è quasi del tutto, per colpa o grazie al progresso della medicina.
Ne abbiamo già parlato su queste pagine a proposito Del nascere e del morire (il foglio 323). Ora dobbiamo ripartire di lí. Dalla presa di coscienza che sempre piú il nascere e il morire sono passati, nella storia della nostra cultura laica e religiosa (sí anche religiosa), dalle mani di Dio alle mani dell'uomo. Il nascere e il morire in sé, come questioni ultime, restano mistero, ma questo nascere e questo morire, in senso concreto, storico e specifico sono un problema e i problemi sono questioni che l'uomo ha il compito di risolvere e il dovere di farlo con responsabilità, misurando i pro e i contro delle sue decisioni. Questo è esattamente quello che si chiama etica, scelta libera e responsabile, razionalmente ed emotivamente coinvolgente, interamente umana, anche quando dovesse (e per i credenti lo deve) coinvolgere Dio.
Fino a ieri, l'idea che l'uomo non può disporre del nascere e del morire, quindi non può intervenire per regolare le nascite e per facilitare o ostacolare il morire, altrimenti porrebbe se stesso al posto di Dio, si farebbe Dio (supremo peccato, anzi «peccato originale»), era il cavallo di battaglia dell'integralismo religioso immediatamente post-illuministico. Tale è rimasto, piú o meno gettonato dalle autorità vaticane, almeno per quanto riguarda la responsabilità delle nascite e la proibizione di ogni iniziativa in merito alla «buona morte», fino quasi alla fine del primo dopoguerra. Poi si è cominciato a riconoscere che le nascite possono essere regolate, ma seguendo un metodo naturale (capziosamente inventato), e che alla morte ci si può contrapporre con opportune cure, persino con trapianti, ma non con l'accanimento terapeutico. Qualcuno ha continuato a parlare di poteri di Dio usurpati dall'uomo, ma con sempre minore convinzione. Oggi la barriera di difesa innalzata delle autorità religiose ad ogni intervento, definito «non naturale» o «artificiale» dell'uomo, in questi campi, è diventata non piú il diritto di intervento diretto di Dio sul nascere e sul morire, ma la «legge naturale», stabilita da Dio con la creazione e con valore universale e razionale, come unico vero criterio per regolare la vita umana.
Il cristianesimo vaticano è diventato cosí la religione del «diritto naturale», con una visione filosofica «teista», se non «deista», del Dio di Abramo, di Mosè, di Gesú Cristo, una visione che si avvicina molto di piú alla religio civilis della latinità imperiale, che alla "religione rivelata" di biblica radice. Se la Roma dei papi fa ancora appello al Cristo e all'eredità apostolica, lo fa ormai solo per farsi unica e legittima interprete del volere di Dio, espresso nel «diritto naturale» e nella «retta ragione»; «retta», appunto, perché guidata dal papa e dalla sua interpretazione razionale-tradizionale della Chiesa. Una Chiesa, non piú solo «esperta in umanità», ma ormai custode delle radici culturali e identitarie dell'Occidente, di cui, come erede della fusione di Atene e Gerusalemme in Roma, culla di verità e di diritto, si sente l'unica in grado di legittimare il potere.
Ha qualcosa a che fare tutto ciò con l'esperienza umana del nascere e del morire, con il lungo travaglio della riflessione biblica su questi temi, dall'esperienza mosaica e profetica alla riflessione sapienziale genesiaca e giobbica, alla parabola tragica e gloriosa del dramma neotestamentario? Francamente no.
Da sempre, no. Perché da sempre l'espressione della fede biblica, come affidamento umano alla promessa salvifica e rivelativa di Dio, si accompagna alla coscienza del mandato divino alla libertà e alla responsabilità della scelta laica del vivere nel mondo. Vivere alla presenza di Dio, nell'obbedienza alla sua legge, storica e rivelata, di rifiuto della violenza e di condivisione, ma anche nella piena autonomia delle proprie decisioni, che proprio perché libere e frutto d'amore a Lui e ai fratelli possono essere pienamente incorporate nella Sua opera di grazia. Vivere contribuendo attivamente, con il Suo aiuto, alla realizzazione del Suo disegno di redenzione-compimento della creazione attraverso la storia umana, che diventa cosí anche storia di Dio, storia del mondo, con tutto il suo carico di colpe e di errori umani e di molteplici e controverse iniziative correttive e redentive di Dio, culminanti nella kenosi della Croce e nell'annuncio di resurrezione.
Al di fuori di questo orizzonte di libertà creativa di Dio e di libertà operativa dell'uomo nulla della fede biblica può essere capito e nulla del contributo che essa può dare al vivere umano.
Di fronte alla vita tanto Dio quanto l'uomo stanno come libertà operative. Libertà infinita quella di Dio, ma kenoticamente autolimitantesi per dare spazio alla umana risposta di comunione. Libertà limitata e, fin da principio, zoppicante e ferita, quella dell'uomo, ma mai inutile e superflua, come l'umanità del Cristo dimostra. Come evidenzia la missione da lui affidata ai discepoli e il suo riconoscersi misteriosamente presente in ogni uomo soccorso e soccorritore nel bisogno.
Ma la stessa cosa vale per Dio e per l'uomo di fronte alla morte, come ultimo atto della vita e anche come suo abbandono e sua fine e, forse, sconfitta. Stanno in un tu a tu vitale e mortale ad un tempo. Il Dio della vita deve dimostrarsi piú forte della morte e l'uomo deve essergli compagno in questa lotta. L'umano-divinità di Gesú sulla croce sta a dirci questa verità drammatica e questo snodo del vivere, che è il far fronte alla morte, uscendone con speranza di vita.
La natura e le sue leggi, la storia e le sue dinamiche giocano il loro gioco, terreno e umano, interamente laico, a cui l'uomo deve far fronte con gli strumenti della sua ragione e della sua passione, della sua cultura e della sua libertà moralmente orientata. Dio ha scelto di lasciarle liberamente agire, riservandosi al piú il giudizio ultimo su di esse, riservandosi l'agire sui cuori e sulle menti con l'illuminazione dello Spirito, confidando nelle potenzialità positive dell'uomo, fatto a sua immagine, e della natura, chiamata a vivere gratuitamente la propria gratuità. Dio ha scelto di farsi compagno dell'umano morire dell'uomo, per farsi compagno anche della sua potenziale rinascita, lasciandogli, attraverso la fede nel Risorto, la speranza di resurrezione e di giustizia ultima, di cieli e terre nuove e di una società redenta dal male e dalla morte. Nulla di piú, ma anche nulla di meno, secondo la fede biblico-evangelica.
Questo significa che Dio, di fronte alla morte, ci lascia armati e disarmati ad un tempo. Armati della fede e della speranza, disarmanti da ogni certezza che immunizzi dal dolore dell'abbandono. La teologia stessa che ci testimonia questa presenza di Dio, accanto a noi nella morte, ci dice che tale presenza ha fin dall'origine diversi volti. I volti delle narrazioni evangeliche dalla "Passione" Quello dell'esperienza della solitudine nella morte e dell'agonia gridata fino all'ultimo respiro, lotta disperata che scuote la fede dalle fondamenta, ma non la perde e la conserva come riserva di possibilità future (Marco e Matteo). Quello della morte vissuta in compagnia di altri, che di noi hanno compassione e ci accompagnano e aiutano ad abbandonarsi al Padre, in piena fiducia (Luca). Quello della morte compianta da familiari ed amici, compimento di una vita, suo coronamento e realizzazione; la morte come ultimo atto di vita che genera vita dal proprio stesso darsi (Giovanni).
Cosí è delle nostre morti. Non tutti moriamo e moriremo allo stesso modo. Tutti abbiamo sotto gli occhi lo strazio della morte mai compiuta di Eluana e abbiamo visto morti atroci e lunghissime di parenti e di amici. Morti improvvise di giovani, traumatiche, tragiche, violente. Morti causate da odi e guerre inestinguibili, da progetti criminali e criminogeni di stermini efferati. Morti nel sonno. Passaggi indolori dall'esserci al non esserci piú, senza scosse o angoscia. Morti centellinate in serenità. Maturate da una vita saggia e fortunata, fino quasi alla fine, come quella di cui parla, come di un progetto, destinato, però in ultimo, a esiti non piú valutabili, il filosofo credente Paul Ricoeur nel suo Vivo fino alla morte (Effatà, 2008). Morti che sono testimonianza di vita e si chiudono con testamenti che sono benedizioni per chi continua a vivere, come nel caso ideale dei patriarchi. Ma anche morti disperate oltre ogni dire, nel patire fisico e morale, e morti anticipate sulla morte fisica, di demenze prolungate, coma senza vie d'uscita, morti di bambini mai nati.
Su tutto questo la parola biblica, le parole della fede poco hanno a che fare materialmente per cambiarne il destino, se non l'accompagnamento e la condivisione. La materialità storica e sociale di queste diverse morti è affidata alla cura terrena del vivere e dell'umano e laico sapere e provvedere, che ha il compito, e sa di averlo, di rendere possibile una loro umanizzazione sempre maggiore, una loro sempre piú piena liberazione dal dolore e dai condizionamenti esterni forzati e forzosi, che penalizzano oltre misura la fatica già grande del vivere e del morire. A questo compito tutti come uomini siamo chiamati in piena parità di diritti e di doveri.
Ma perché mai i vertici della Chiesa Cattolica, auto-proclamandosi "Vicari del Cristo", al di là e oltre tutto ciò, non possono annunciare speranza di vita e di accoglimento da parte di Dio di ogni morte, invece che farsi giudici e amministratori gelosi del potere di decretare chi, come, quando si deve morire, e arrogarsi il diritto di negare l'ultima benedizione del Padre a chi ha scelto di morire per mancanza assoluta di vivibilità della vita? Perché mai chi si richiama al nome del Dio della vita e del Figlio Suo, crocefisso e risorto, deve arrogarsi quel potere sul controllo della morte, che, se dobbiamo dare credito a Sapienza 2, 24, è di origine satanica?